ALFREDO PANZINI
La cagna nera
(1895)

*
Quando arrivai era una domenica: domando a uno, domando ad un altro dove erano le scuole e nessuno mi sapeva indicare. Finalmente un prete seppe dirmene qualcosa. Vado su, su per una viuzza stretta, sucida, con tutte le comarelle presso gli sporti e i ragazzi che si ruzzolavano da presso.
Qualche cosa come un’insegna e una scritta pendevano da una porta un po’ piú grande delle altre: supposi che quella fosse la scuola, ne mi era sbagliato.
Un uomo che stava in un stambugio, intento a legare dei libri (era il custode) mi precedette su per le scale, aperse la porta di una stanza, mi annunciò; e allora vidi un uomo di mezza età, vestito di nero, levarsi dallo scrittoio e venirmi incontro con un «oh!» che sonava un po’ meraviglia e un po’ rimprovero perché, come mi disse poi, mi attendeva già da qualche giorno. Era il direttore di quel ginnasio.
Un’altra persona era con lui; un vecchietto mal vestito e tabaccoso che al mio arrivare salutò rispettosamente ed uscí.
Quando fummo soli, quel signore cominciò senz’altro a darmi moltissime informazioni di cose scolastiche con una voce cadenzata e lenta di cui non percepivo che il suono, però mi scossi dolorosamente quando disse:
— .... io so da private informazioni che ella non è fornito di diploma e che questo posto le fu concesso per singolare favore, e tenuto anche conto delle benemerenze della di lei famiglia. Questo perciò le impone l’obbligo di studiare, di fare del suo meglio e vedere di procacciarsi nel piú breve tempo possibile l’abilitazione che si richiede....
Poi parlò della carriera, e infine dello stipendio che avrei percepito.
— Ma come si fa a viverci? — domandai con dolorosa sorpresa perché quella somma per me rappresentava a pena il salario di un cuoco o di un cocchiere di casa signorile; ma come è facile pensare, tenni questo pensiero per me.
— Eh, signor mio — rispose lui sorridendo e posando con indiscreta curiosità lo sguardo su la eleganza del mio vestito — certo è che bisogna adattarsi e sapere contare il valore del danaro. Ma infine ella è scapolo e la vita qui non è costosa. Vi sono stanze decentissime a quindici lire il mese, ed ella può trovare una pensione soddisfacente a cinquanta lire. Veda quindi che le rimane piú che metà dello stipendio per ciò che è vestiario e minuti piaceri....
Io non risposi; so che mi sentiva come un freddo di avvilimento a quelle parole. E poi quel tuono di superiorità e di autorità mi sonava nuovo; mi rimescolava tutto di dentro e nel tempo stesso mi incuteva rispetto. Di queste gerarchie di uomini che comandano agli altri, non aveva la piú lontana idea. Ma dunque vi sono di quelli che vestono non la livrea, ma come noi e pure vivono tutta la vita sotto la soggezione degli altri?
— .... E che dovrebbero poi dire — proseguiva lui — quelli che sono carichi di famiglia? Il signore che è uscito poco fa e che era qui mentre ella è entrato, ha cinque figli....
— È un professore quello lí? — domandai meravigliato.
— Certamente, è il prof. B***, suo collega. Veda: ha cinque figli, e un po’ con la paga, un po’ con qualche lezioncina nelle vacanze, viene a sbarcare il lunario. Ed ora, se ella crede, le farò vedere la scuola....
Si alzò; anch’io mi alzai automaticamente. Egli passò davanti senza far complimenti ed io lo seguii.
Un corridoio girava tutto attorno ad un porticato e in mezzo vi era un cortile con un pozzo. Intravvidi e sentii come un silenzio triste di cose melanconiche. Egli aperse una porta, passò avanti, e:
— Ecco la scuola — disse —, piccola ma una delle migliori.
Voltai gli occhi attorno: le pareti erano giallognole, nude; tre file di banchi tagliuzzati si allineavano davanti alla cattedra che era in forma di tavolo. E mi parlò di altre cose di scuola. Infine mi accomiatò con un:
— A domani, dunque; alle ore otto.
Ritornai all’albergo; mi sedetti su di una sedia con la fronte su la mano, e stetti come smemorato. Dai cristalli si vedeva il mare, su per l’aria veniva ogni tanto una accidiosa cantilena o grido di venditore che fosse.
— Suvvia, finiamola! — dissi, e mi alzai con l’intenzione di rimettere ne la valigia i pochi arnesi di toilette che avevo tirato fuori, riprendere il treno, ritornare a F***. — Ma e poi, che cosa faccio? — Questa fu la dolorosa domanda.
Nel portafoglio mi rimanevano a pena duecento lire. Bisognava ricorrere per forza a mia madre e con quale animo, sapendo che ella non poteva piú mandarmi nulla; e dopo che le avevo annunciato della mia nuova occupazione? E notare: passando per Napoli, io avea trovata una lettera di Beppo in cui mi diceva che dal giorno che avea saputo del nuovo ufficio, in tutto degno del mio nome, ella pareva rinata a nuova vita. Che cosa dirle, come spiegarle il ritorno improvviso?
E come a quella disperazione subentrò un senso di abbattimento profondo, cosí anche cadde la forza della mente e della volontà per decidermi sul da farsi.
Rimasi. Mi rivedo per la prima volta nella scuola. Loro, gli scolari, si guardavano sorpresi come a domandarsi: «Chi sarà, chi non sarà? ti pare che si possano tirar le pallottoline e giocare, e far chiasso con quello lí? ti pare?» Io pure guardavo; e in quell’angusto spazio mi sentivo stretto e molto avvilito fra quei bambini, come io fossi stato un grosso giocattolo.
— Oh mio Dio! — esclamai fra me — dove mi sono andato a cacciare! Se mi vedessero i miei amici di F***, ne riderebbero per un mese... Carlo B*** ne farebbe la caricatura per tutti i salotti.
A questo pensiero arrossii lievemente e mi sentii sconsolato. Pure erano dolci e soavi quei volti e ogni tanto, vedendomi silenzioso e triste, si consultavano, allungavano le loro boccucce e parevano anche pensare: «Deve essere uno di quei professori cattivi! Chi sa a che cosa medita, chi sa che domande difficili ci farà mai adesso!» Qualche cosa bisognava pure che io in fine dicessi; ma lí per lí quelle poche regole di grammatica che sapevo e avevo ripetuto, mi giravano come un arcolaio, e non ci riusciva a prenderne una. Ma qualche cosa bisognava ben dire!
V’era un ragazzetto che poteva avere un tredici anni con due occhi neri, tanto vivi che parlavano da soli a due labbra capricciose su cui i denti davanti sporgevano fuori. Su di lui si posò la mia attenzione.
— Come si chiama lei? — domandai.
— Weiss! — e scattò in piedi come un fantoccino a molla.
— È tedesco?
— Io no, mio babbo sí...
— È quello che ha l’Hôtel des Etrangers ai Cappuccini... — saltò su a dire un altro; ma subito capí la grave infrazione di aver aperto bocca senza essere stato interrogato; diventò tutto rosso e si sedette vergognoso e confuso.
— Bene, mio caro Weiss — ripigliai — sentiamo un po’ lei....
Si fece un silenzio assoluto; e l’interpellato arcuò la mente per richiamare tutte le sue cognizioni grammaticali, raccolte con tanta fatica e disperse con altrettanta facilità per i campi e fra gli spassi.
— Bene — ripetei posandogli la mano su la spalla — bene, lei ama sua mamma e suo babbo?
— Oh sí, tanto!... — rispose arrossendo e traendo un sospiro di sollievo.
Anche gli altri respirarono. La domanda non era stata difficile.
— Bravo, dunque; e quel ritratto che è appeso lassú di chi è?
— Del re! — rispose piú d’uno a gara.
— E il re che cosa rappresenta?
La domanda era difficile. Anche l’alunno Weiss si mordeva le labbra inutilmente.
— Il re — dissi io allora — rappresenta la nostra patria, l’Italia; e, sotto, osservate quel crocifisso che vuol dire la religione: dunque tre grandi cose voi dovete avere in mente; la famiglia, la patria e la religione... — e su questo tema conversando, finii per distrarmi dall’oppressione che mi durava nel cuore; e quando la scuola fu terminata e i ragazzetti si allineavano in doppia fila, sentivo che dicevano
— Questo sí che è un buon professore! hai sentito tu quante belle storie ci ha raccontato?
Mi vennero poi presentati i colleghi. Ne ebbi l’impressione di brava gente; solo il tratto mi parve un po’ rozzo; ma forse erano anche impacciati non sapendo che cosa dirmi, giacché dal modo con cui mi guardavano di sottecchi, sembravano pensare: «Ma questo qui da dove è capitato? non ha mica l’aria d’essere dei nostri!»

(Da: A. PANZINI, La cagna nera, Roma, «La Voce», 1921, pp. 44-52. Per un breve inquadramento e qualche altro passo di quest'opera cfr., tra gli Studi della sez. Letteratura e Territorio, G. CENTONZE, Castellammare nella letteratura italiana del secondo Ottocento)
(Fine)
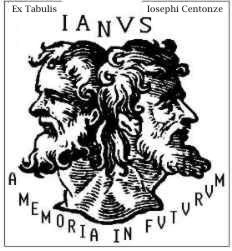
|
Altre Testimonianze |