|
|
GIUSEPPE CENTONZE
San Gennaro non dice mai no
(Maggio-Luglio 2010)

Il 1947 fu l’anno della pubblicazione e dell’immediato, grande successo de L’oro di Napoli. L’autore, il giornalista napoletano Giuseppe Marotta (1902-1963), che viveva a Milano dal 1925, vi aveva raccolto trentasei bozzetti sulla povera gente della città natale, già apparsi come elzeviri sul «Corriere della sera»; trentasei storie che avevano rivelato nel cronista lo scrittore, facendogli acquistare finalmente sicuro «credito tra i letterati», come egli stesso dirà.
Il bisogno di richiamare alla memoria e di narrare la sua Napoli, nel periodo disastroso del dopoguerra, era stato incontenibile:
«Ho vissuto molti anni lontano dal mio paese [...]; d'improvviso Napoli e la mia giovinezza e persone e vicende che la abitarono o che si affacciarono appena si sono messi a chiamarmi».
Un bisogno provocato dall’amore:
«Voglio bene, perché ci son nato, al mondo dei vicoli e della povera gente del mio paese. Di tutti i suoi mali sono depositario e amico, ne parlo perché li conosco, ne parlo con la speranza di giustificarli, di dimostrare che prima di risolversi in colpe i mali di Napoli sono soltanto dolore».
E
tuttavia, accanto a questo dolore, egli aveva intravisto nei napoletani
un’innata, paziente capacità di accettarlo, che costituiva in fondo la loro vera
ricchezza: l’oro di
Napoli.
Nello stesso anno ritornò a
Napoli, dopo vent’anni, per rivedere la città segnata dalla guerra e divenuta
«tutta un rione popolare»; osservò e scrutò con amore per descrivere le sue
impressioni in pagine di viaggio, ancora una volta con intenzioni «oneste e
affettuose», ancora una volta per il «Corriere della sera», poi raccolte in
San Gennaro non dice mai no
(Milano, Longanesi, 1948): un «romanzo», come recita il sottotitolo, o soltanto
un «libretto» che «è la piccola storia di un mio viaggio a Napoli», come egli
stesso affermò nella prefazione.
Aggiunse nella stessa prefazione:
«So
già che molti, napoletani o meno, non vorranno saperne delle mie impressioni,
deploreranno sia i miei colori che le mie figurine. Non è vero, diranno, che
contro i piú antichi muri di Napoli i venti e gli uomini si grattano da secoli
la schiena; diranno: lei non ha visto niente, travisa e anzi diffama una città
[...]. Scrivendo finora su Napoli non mi sono mai illuso di superare i limiti
dell'annotazione, di un pro-memoria: su una sola corda di chitarra o forse mezza
ho strimpellato una rozza cantilena alla mia città, quando, scomparsi Di
Giacomo, la Serao, Russo, a nessuna musica essa diceva piú niente; ben vengano
ora i
primi violini».
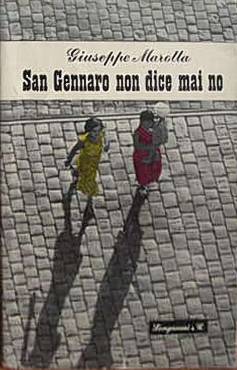
In
San Gennaro non dice mai no
Marotta descrisse la Napoli del dolore e delle
sofferenze con benevolenza, con affetto, con ironia, a tratti con la sua stessa
partecipe sofferenza.
La visita ai paesi della costiera
sorrentino-amalfitana fu dovuta proprio alla necessità di distrarsi, di evadere
in seguito ad una penosa visita all’Ospedale dei Pellegrini.
Cosí diede inizio al dodicesimo capitolo (Riviera):
«Sono
pusillanime, non reggo alla vista dei sofferenti, uscendo dall'Ospedale dei
Pellegrini mi dicevo: "Domani vado a dare un'occhiata ai paesi della riviera", e
cosí
feci».
Cominciò proprio da Castellammare, presentata come una città da proporre magari ai vecchi industriali milanesi per trascorrervi gli ultimi anni di vita, date le sue caratteristiche di stazione balneare, termale e climatica, cui però non mancavano officine e fabbriche produttive:
«La
mia prima tappa fu Castellammare di Stabia, l'antica cittadina di cui subito si
pensa: qui i vecchi industriali e commercianti milanesi dovrebbero venire a
trascorrere i loro ultimi anni, s'intende dopo aver lasciato le loro aziende in
mani sicure, e salvo a telefonare ogni sera istruzioni e rimbrotti.
Castellammare è una celebre stazione climatica, balneare e termale; irta di
ciminiere però, disseminata di officine e di fabbriche, piena di buste-paga,
sorvolata da estrose nuvolette che potrebbero benissimo simulare, per i canuti
uomini di cifre riversi nelle amache, i piú lusinghieri diagrammi. Castellammare
è insomma
Chianciano, Rapallo e Monza
in una sola nitida e leggiadra cittadina; ha un
lido carezzevole e mansueto, ha una mitissima
temperatura,
ha le terme, ha non so quanti biscottifici
e pastifici che le consentono di allestire vetrine di nivei spaghetti,
ha nella piazza Municipio una bella
targa che vi fa sospirare di nostalgia perché
dice: "Al marchese De Turris, donatore del pingue patrimonio di L. 200 mila a
questo Spedale di San Leonardo". Ah marchese, come ci lasciano freddi oggi le
vostre duecentomila lire che non basterebbero a rimettere in piedi un solo uomo,
anzi non risanerebbero neppure uno dei tanti alberi secchi di questo bel
Giardino Pubblico davanti al mare, poveri alberi uccisi dalle infiltrazioni di
benzina dei carri armati che vi sostarono durante la guerra».
I segni lasciati dagli alleati nella villa comunale si prestavano ad una particolare considerazione:
«Le
truppe alleate che presidiarono Castellammare di Stabia furono in massima parte
inglesi e non hanno lasciato buon ricordo; assunsero un contegno altezzoso e
sprezzante che non poteva piacere agli stabiesi. Questa
è gente arguta e fiera, con molti fatti
e persone insigni nel suo passato; e di ciò va sempre tenuto conto
quando si viaggia, sia pure come vincitori di guerre».
Simpatica la descrizione del centro, molto animato, elegante anche nell’esposizione delle merci, messo a confronto con quello piú ‘paesano’ di Gragnano:
«Castellammare
di Stabia ha, fra piazza Umberto e
piazza
Municipio, la sua piccola Toledo. Bei
negozi di eleganze e di
squisitezze (queste ultime in proporzioni normali, non come a Gragnano, dove si
vedono dondolarsi nelle mostre caciocavalli vittorughiani, alti come uomini,
biondi e massicci, ai quali deve essere terribile avvicinarsi col coltello in
mano); ma sovrattutto la folla densa e ridente di Toledo, che pare si rechi
sempre a una festa».
La visita al cantiere navale offrí l’occasione per mostrare la dedizione degli operai, i quali l’avevano ricostruito dopo il passaggio dei tedeschi ed ora lamentavano la mancanza di materie prime, che limitava anche il loro lavoro:
«Al
Cantiere Navale, mentre lo visitavo,
attaccai discorso con qualche operaio nell'atrio. I Tedeschi, prima di
andarsene, eseguirono anche qui il solito arpeggio di mine; ma, in pochi mesi,
poi, gli operai stabiesi ricostruirono tutto. L'affetto che li lega al Cantiere
può
essere meglio valutato se mentre essi dicono: "Scrivete che il lavoro è
insufficiente, ci occorrono materie prime" il visitatore legge, nelle apposite
lapidi, gli elenchi delle navi costruite dagli avi di questa gente che gli
parla: capolista è la corvetta Stabia varata nel 1786; regnavano i Borboni,
allora, cosí amici dell'Inghilterra, e comunque la materia prima era il legno».
Naturalmente c’erano da visitare le terme, con il distintivo tanfo delle acque e il numero straordinario di sorgenti:
«Lo
Stabilimento termale sorge proprio dirimpetto al Cantiere. Castellammare
è cosí stretta fra la montagna e il mare che utilizza il suo spazio come
meglio può.
Dallo Stabilimento termale si diffondeva una remota freschezza di selva,
di grotta e di creta. Sono luoghi,
questi, in cui anche l'uomo meno disposto a riconoscersi nella terra
sente trasalire la sua sostanza, capta nel tanfo delle acque, venute da chi sa
quali profondità, antichissime e vaghe notizie di se stesso. Bene, io non mi
aspetto di conoscere niente di buono sul mio conto e perciò l'odore soverchiante
dello zolfo mi fece torcere il naso; ma queste acque di Castellammare di Stabia
sono vere? non si tratta di uno scherzo? ci si può credere? qui in questo
angusto recinto, una accanto all'altra come tasti di pianoforte scaturiscono
ventotto, diconsi ventotto, acque minerali l'una diversa
dall'altra?».
Intorno al miracoloso numero delle fonti veniva fuori la vena spiritosa dello scrittore:
«Ero
scettico e volli verificare, contare e perfino
assaggiare. Inutile, erano ventotto
fonti; una singolare raccolta, una rara collezione di sorgenti che il
Dio degli abissi e delle vette
mostra qualche
volta ai suoi ospiti,
forse pavoneggiandosene
e intenerendosene un poco; ero giovane e contento, dice, quando mettevo insieme
queste cose».

Cosí come era chiara la sua bonaria ironia a proposito delle numerose virtú terapeutiche delle acque:
«L'elenco
delle infermità che le acque di Castellammare possono curare s'allunga ogni
volta che viene scoperta una malattia nuova. Dovetti
sorridere all'idea di individui che trasportati in
barella
nello
Stabilimento scorressero l'elenco delle
acque e finissero per dire mestamente: "Riportatemi a casa, ho soltanto un terzo
delle malattie che occorrono
a queste
fonti, ripasserò"».
Vale la pena riportare anche quel che annotava a proposito dell’affollato autobus che portava da Castellammare ad Amalfi:
«Da
Castellammare di Stabia un autobus vi porta
- se ve lo siete meritato, e cioè se sapete perforare
la
folla irrompente - ad Amalfi. Mi scavai una galleria fra gambe braccia e
valigie, sedetti su un cappello che qualcuno poi riconobbe e riadottò
all'arrivo, vidi passare sulla tortuosa carrozzabile che si
solleva e ricade strenuamente fra tipiche balze alpine i comuni di
Gragnano, Pimonte, Agèrola, nei quali mentre da una parte si asciugano al sole
gli spaghetti che presto o tardi mangerete, dall'altra cresce l'uva per il vino
con cui se mi date retta potrete meglio gustarli».
Anche la bellissima strada da Castellammare a Sorrento era citata, con il riferimento ad alcuni illustri scrittori stranieri che l’avevano lodata (tra i quali Goethe, che in verità non mi pare l’abbia mai attraversata), senza poter reggere al confronto con la bravura di Dio creatore:
«Sulla strada che se ne va passo passo, irresoluta e sonnolenta, attardandosi per ogni onda o gabbiano che vede, da Castellammare a Sorrento, si pronunziarono Dickens, Taine, Ibsen, Goethe, Stendhal e non so quanti altri, per dire, tutto sommato, che è la piú bella strada del mondo. Quando, in queste descrizioni illustri, vedete ricomparire ogni tre righe la parola "divino" o la parola "sublime", gettatele nel fuoco perché è evidente che ai loro autori gli venne il fiato grosso, non vollero con semplicità riconoscere che una volta tanto, come paesaggista, Dio era stato piú bravo di loro».
Marotta la percorse in un tram dalla lentezza incredibile, che come l’autobus per Amalfi rivelava gli enormi disagi allora affrontati dai viaggiatori:
«Nell'arcaico
tranvai, che partí fragorosamente, come se spezzasse una catena, si alzò tutt'a
un tratto una bambina e senza preavviso, con
una vocetta acerba e gobba, cantò
una satira
delle "segnorine" il cui ritornello, alludendo allo chewing-gum che
sembrava aver fatto strage da quelle parti, sanciva: "Avevi un volto di
madonnella - ma l'hai succhiata anche tu la caramella". Dopo aver concluso, in
prosa, che c'era poco da sorprendersi perché anche lei doveva vivere, la bambina
fece apparire un piattello e questuò. Ma la lentezza di quel tranvai; qualche
viaggiatore scendeva per sgranchirsi le gambe, poi si sedeva sul muricciolo,
aspettava che il tranvai lo raggiungesse e vi riprendeva il suo posto».
L’episodio della bambina che cantava con malinconica malizia, usata come strumento per la sopravvivenza, riportava ai piú gravi problemi e alle miserie dei napoletani del dopoguerra, i quali ancora una volta dovevano pazientemente aspettare un domani migliore, sapendo che a loro il santo protettore non diceva mai no.

(Da «L'Opinione di Stabia», XIV 135 – Mag.-Lug. 2010, pp. 18-19).
(Fine)
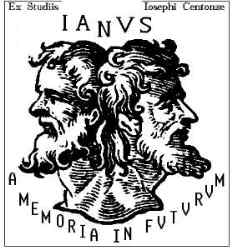
|
Altre Spigolature |