|
|
GIUSEPPE CENTONZE
«Coppie» e «La vita in due» di Clelia Pellicano
(Settembre-Ottobre 2009)

Profondamente
legata a Castellammare fu la marchesa Clelia Romano Pellicano, femminista
impegnata e scrittrice coraggiosa, che vi trascorse importanti anni della sua
vita, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.
Nata probabilmente a Napoli nel 1873 - in verità le fonti sono discordi sul
luogo e l'anno di nascita - in una famiglia di patrioti (il padre era il barone
pugliese Giandomenico Romano giurista e deputato al Parlamento, la madre era
Pierina Avezzana, figlia
del generale garibaldino e deputato Giuseppe e di una donna irlandese),
nel 1892
sposò
«in un raro e felice connubio della ragione e del cuore» il marchese di origine calabrese Francesco Maria
Pellicano, nato a Napoli nel 1855, e andò a vivere nella villa stabiese dei
Pellicano a Quisisana.
Qui, quand'era ancora giovanissima e già madre dei primi
due dei suoi sette figli, cominciò a scrivere delle novelle, apparse nel 1899
sulla rivista «Flegrea» con lo pseudonimo
Jane Grey
e inserite poi in
Coppie (Napoli, Pierro e
Veraldi, 1900), una raccolta di varie e particolari storie o situazioni di
ménage,
che suscitarono scalpore tra i benpensanti del tempo, ma anche alcuni positivi e
importanti giudizi critici, che la incoraggiarono a continuare la sua attività
di scrittrice. Ed infatti Jane Grey pubblicò ancora nel 1908, presso la Sten di
Torino, le
Novelle calabresi, spostando tuttavia il suo
interesse verso temi regionali.
Il successivo 1909 segnò una svolta nella vita di Clelia, che in quell'anno
perse il marito e fu costretta a interessarsi da sola dei figli e del
patrimonio; segnò una svolta anche per la sua attività culturale e sociale: ella
pubblicò infatti su «La nuova Antologia» un'inchiesta sulle industrie e le
operaie di Reggio Calabria, partecipò al
Congresso femminile di Londra per il voto alle donne
e iniziò a svolgere un'intensa attività di propaganda femminista, di conferenze
e
di articoli sulle condizioni e i diritti delle donne. Si spostava tra
Castellammare, Gioiosa Jonica, Napoli e Roma, e nella capitale tenne un noto
salotto frequentato da letterati, artisti e politici.
Dopo la prima guerra mondiale vide la
luce la seconda edizione di
Coppie col nuovo titolo
La Vita in due
(Torino, Sten, 1918), che qui utilizziamo, comprendente le stesse storie, con
qualche lieve rifinitura. Ne riportiamo i passi che più interessano le nostre
Spigolature
Stabiane.
Si parla di Castellammare nella novella
Luna di miele,
in cui Beatrice (Biciuzza), che si trova a Sorrento col marito Lillo, in luna di
miele per l'appunto, racconta all'amica Graziella la sua sconvolgente giornata,
la sua «ultima giornata di sole», degenerata alla fine in una inaspettata
esplosione di gelosia. I due hanno fatto una gita a Cava, percorrendo in
carrozza la strada fino a Castellammare, qui hanno preso il treno per Torre
Centrale e a Torre quello per Cava, ma il caso ha voluto che abbia viaggiato per
un tratto con loro il conte di Mora, l'antico fidanzato di Biciuzza, il quale,
tra confidenze, dicerie e impertinenze, ha inoculato nell'animo della donna il
veleno di dubbi e sospetti sul passato amoroso del marito, una volta
inconsistenti o sottovalutati e da questo momento sempre più radicati e
struggenti, fino ad esplodere al ritorno a Sorrento.
In relazione a Castellammare e alla sua stazione, dove la
«bellissima» cittadina rivelava spesso le sue contraddizioni, è interessante il
racconto dell'originale raggiro subito da Biciuzza, ad opera di un presunto
facchino, per un suo bagaglio, uno «scatolone» con qualche abito per la gita, da
spedire come collo appresso:
«Era mezzogiorno preciso all'orologio di Lillo, e a quello della stazione,
quando, lasciata la carrozza con l'ordine di trovarsi a Torre Annunziata alle 7,
saltiamo nel treno che alla Centrale si cambia per quello di Cava. Mancava
mezz'ora alla partenza: ne profittiamo per ispedire con comodo il bagaglietto -
uno scatolone di fibra - dove avevo cacciato alla rinfusa un po' di biancheria e
qualche vestito.
- Perchè questo
collo appresso?
- ha chiesto Lillo, di malumore.
-
Ma... non si sa mai: potremmo non tornare stasera. Un uragano, un malessere, la
perdita del treno, un incidente qualsiasi... Brontoli perchè mi mostro
preveggente?
- Non accadrà nulla: e poi, una valigia bastava!
Infatti una valigia sarebbe stata da preferirsi; ma io sono stranamente
affezionata a quel mio scatolone e me lo porto dietro tutte le volte che mi
riesce.
- Abbi pazienza... è così comodo! dico, a mo' di scusa.
- Comodo? Non direi! - E Lillo lo consegna, con un biglietto da dieci lire, ad
un facchino che, avendo fiutato la preda (forestieri... e sposi!...) ci ronzava
intorno offrendo servigi in un dialetto sghangherato e rumoroso come una vecchia
ciabatta.
-
Sta bene, Signurì! Mò vaco e torno. Vulite spedì? E lassate a me! Io so'
Catiello: Vui sapite a Catiello? Catiello 'e Castellammare!...
- e gesticolando, vociferando, correndo, sparisce
col mio scatolone in un buco nero».
La mezz'ora di attesa nel vagone fermo passa tra gli sbuffi di Lillo che
«detesta l'immobilità»
e l'ansia di Beatrice per il suo «scatolone»,
che non viene
riportato. Poi, «uno stridore di ferramenta, una
scrollata vigorosa e... il treno fa per prender la corsa». Allora il conte di
Mora, che ha atteso sul marciapiede «balza dentro d'un salto», fermandosi
accanto ai due sposini, mentre Beatrice è ancor più preoccupata per il bagaglio.
Ecco il prosieguo dell'azione:
«Il treno s'incammina davvero.
- Oh Dio! Il mio bagaglio! Lillo! il mio bagaglio!
- Eccolo! - esclama Lillo. Siamo tutti e tre allo sportello. E vediamo
Catiello,
col mio scatolone sotto al braccio, correre con tutta la forza delle sue gambe.
S'aggrappa a non so quale sporgenza del treno, ci accompagna correndo per un
tratto. E intanto gesticola, vocifera, spiega:
- Aggiate
pacienzia... ...All'urtemo momento chillo... nun a vuluto spedì!
Dice che passava le dimensioni
regolamentari! Che ce vulite
fa? Chesta è a camorra 'e Castiellammare. Teccove 'o bagaglio...
(e ci scaglia dentro lo scatolone che ruzzola sul divano)
Purtatevello cu' vui ca
nisciuno ve dice niente! E teccove 'o riesto!
- e getta a Lillo un biglietto da 5 lire.
- Chillo 'a
vuluto tre lire pa' spedizione; doje lire me so' tenute pe' me, ch'aggio perduto
mez'ora, signurì! Tutto pe' chillu 'mpiso!...
Il treno corre sempre: e Catiello finalmente si ferma ansante col berretto in
mano, in aria tra soddisfatta e contrita.
Lillo intasca filosoficamente il suo resto: io, felice di riavere il mio
scatolone, sorrido. Mora commenta:
-
è
un giochetto che fanno a tutti i forestieri. Prendono il
collo appresso
e, d'accordo col
compare,
fingono di spedirlo. Ma per una ragione o per l'altra, il bagaglio non è in
regola: mal chiuso, oltrepassante le dimensioni ecc. e, quando il treno è in
moto, lo restituiscono al viaggiatore con molte spiegazioni in più... e qualche
lira in meno.
- Dopo tutto è stato onesto - indulge Lillo - Tre lire pel
compare
e due per sé... mentre poteva
squagliarsi
con le dieci lire e il bagaglio!
Ridiamo tutti. Il ghiaccio è rotto».
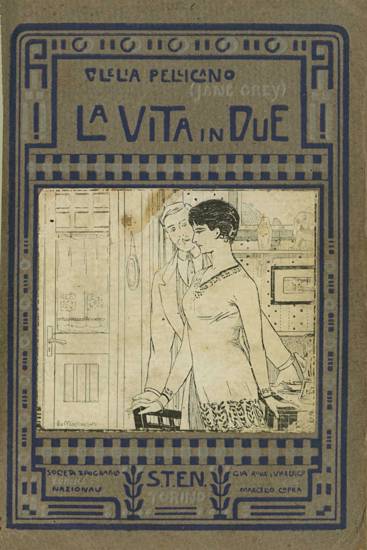
Il seguito della gita comprende le insinuazioni di Mora, la
visita di Cava, quindi il ritorno. Ma è ormai diverso l'animo di Biciuzza, che,
pur attratta dalla magica visione serale del piccolo porto di Torre, non riesce
a goderne: «quale meraviglioso scenario perduto per l'amore!». A Torre i due
sono attesi dalla carrozza che li riporta a Sorrento; attraverso «la campagna
bagnata dal Sarno, oscura e pur ridente del suo riso perenne» arrivano «in vista
di monte S. Angelo, ai cui piedi Castellammare, gaja cittadina bellissima,
splende per mille fiaccole e risuona di canti», percorrono la strada per
Sorrento in un incantato paesaggio notturno. Ma «tutto era bello, inutilmente!»,
a causa del tarlo che ormai scavava sempre più dentro di lei.
Clelia Pellicano non parla di Castellammare nelle altre
novelle della raccolta. In compenso, scrive delle cose molto interessanti nella
prefazione aggiunta a La vita in due,
datata «Marina di Giojosa Jonica, dicembre 1917» ed ovviamente mancante in
Coppie,
a proposito del momento della sua vita in cui le novelle nacquero, del luogo
dove furono composte, della scelta dello pseudonimo, di come furono accolte
dalla critica, di come furono male accolte dai familiari (particolarmente dalla
madre e dalla suocera), del perché della seconda edizione.
Da essa estraiamo la bellissima parte autobiografica, in cui
sono descritti la villa Pellicano a Quisisana e il particolare momento della
vita di Clelia, che vi abitava d'estate e d'inverno, molto amandola ma anche
odiandola, e vi scrisse «le novelle dei miei vent'anni», che «della gioventù
hanno tutt'i difetti e qualche pregio»:
«Era mia dimora, in quel tempo, d'inverno come d'estate, una villa solinga, tra
la montagna e il mare. Situata a mezza costa sulla collina di Quisisana, presso
Napoli, dava le spalle ai monti di Coppola e di Faìto; e si apriva, dinanzi, sul
divino golfo di Castellammare. D'estate, i monti vi gettavano l'ombra folta dei
castagneti, impregnandola di frescura; d'inverno si coronavan di nembi come numi
irati: in ogni stagione offrendo il più bel paesaggio svizzero che si possa
sognare in Italia. Il golfo di Castellammare, ampia conca di smeraldi e zaffiri
orlata da l'agata delle spume, aveva quale sfondo il Vesuvio, superbo della sua
linea classica non anche deturpata da l'ultima eruzione (che lo decapitò, quasi
per castigo) e il suo pennacchio si allungava, a seconda del vento, ora a
destra, sulla ridente pianura di Terra di Lavoro, tappezzata di verde, popolata
di borghi; ora a sinistra, su Napoli che, pur lontana, trasfondeva nel paesaggio
il respiro e il palpito della sua vita immensa. Nello sfondo, le isole di Capri
e di Procida sfumavano, vaporose come sogni: da presso, il Castello di
Rutigliano rompeva, nero scoglio, fuor del mare che lo flagellava o lambiva
d'ogni lato, secondo l'umore. E tutto ciò si abbracciava, in uno sguardo semi
circolare, da l'ampia spianata della villa da me detta «La terrazza del
Paradiso» perchè si protendeva sugli orti odorosi di gelsomino, rosseggianti di
oleandri in fiore; sui poderi che scendevano a valle, nettamente limitati, sul
ciglio, da una filza di pini canori.
Io l'amavo e l'odiavo, quella villa che m'impregnava l'anima di poesia e
chiudeva tra i suoi cancelli, come in una prigione, la mia gioventù impetuosa.
La prediligevo d'autunno, quando, fugato lo stormo dei villeggianti al primo
tuono settembrino, restavamo soli in cospetto del paesaggio colorato di luci
sanguigne, ricco e languido d'espressioni indefinibili; la paventavo d'inverno,
quando non vi giungeva altra voce fuor di quella degli elementi - sibili del
vento, ùluli del mare, rombi e boati del Vesuvio; scoppii di folgore sulla
montagna, scrosci di pioggia e rimbalzar di grandine: degli elementi che la
trasformavano in una bolgia infernale, empiendola d'una vita possente e tragica,
cui mescolavo la mia vita con un senso misto d'esaltazione e d'angoscia. Ero
sposa, e due maschietti biondi già allietavan le nozze, contratte in un raro e
felice connubio della ragione e del cuore. Ma le cognatine e la mamma facevano a
gara per alleviarmene il peso e contendermene la cura; mio marito si assentava
sovente, a lungo; e poi che i cancelli di Quisisana gli si erano richiusi alle
spalle con un cigolìo che mi strideva come lima sottile sui nervi, una
solitudine immensa mi sovrastava, generatrice di fantasime d'arte: il Silenzio
restava a guardia dei miei sogni come l'invisibile drago della favola a difesa
del tesoro incantato.
Fu così che in un divino autunno, mentre la natura cingeva l'agonia della estate
di volubili incanti, sì che questa ad ogni ora mi diceva addio con diverso
sguardo, le novelle della «Vita in due» mi sbocciarono dentro, in una
germinazione tumultuosa e fervida; s'intrecciarono, si snodarono, ora tristi,
ora liete a seconda dell'ora, per librarsi dalla «Terrazza del Paradiso» come
uno stormo di uccelli ebri di volo. Chiedevano di andare pel mondo a cantare
l'eterna canzone delle coppie innamorate, delle umane coppie che l'ebrezza
esalta o schianta il dolore; ma la cosa non era facile. I miei parenti erano
tutti in supremo grado
collet monté
come direbbero i nostri alleati francesi; e le mie novelle
erano ardite...
troppo ardite! Tali apparivano anche ai miei occhi
attoniti, al mio spirito
quasi sgomento di aver loro data la vita. Ma la tentazione era forte. Con la
complicità di mio marito, scappai a Napoli, dove mi riuscì di trovare un editore
disposto a stamparle in nitida edizione».
Dopo La vita in due del
1918, Clelia Pellicano continuò la sua campagna a favore delle donne e la sua
attività letteraria, ma la sua salute le pose un freno e dovette anche
rinunciare a collaborazioni offerte per qualche giornale (ad es. all'invito di
Ugo Ricci o
Triplepatte per i
Mosconi
su «Il Mattino» di
Napoli).
Morì il 2 settembre 1923 a Castellammare, dove
aveva vissuto da giovanissima sposa e madre
e dove era nata Jane Grey.

(Da «L'Opinione di Stabia», III 131 – Set.-Ott. 2009, pp. 19-21).
(Fine)
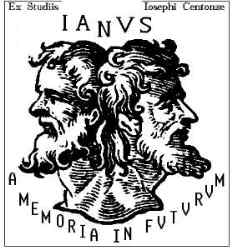
|
Altre Spigolature |