GIUSEPPE CENTONZE
«Cuore infermo» di Matilde Serao
(Agosto-Settembre 2007)

Matilde Serao dedicò una particolare attenzione nelle sue opere letterarie a Castellammare come affollato e fervente luogo di villeggiatura frequentato dall’aristocrazia napoletana nell’età umbertina e a lei ben noto. Lo dimostra ampiamente Cuore infermo (uscito a puntate nel 1880 sulla «Gazzetta Piemontese» e in volume a Torino nel 1881), il suo primo romanzo che la fece conoscere, appena ventitreenne, rapidamente e giustamente come scrittrice di razza.
è la storia d’amore o di un mancato amore tra Marcello Sangiorgio e Beatrice: Marcello, innamorato di Beatrice, ma non ricambiato, si rifugia nell’amore per Lalla e provoca, cosí, la gelosia e questa volta l’amore di Beatrice, per cui nasce una nuova, brevissima storia, interrotta dalla immatura morte di lei.
Gli ambienti della vicenda sono Napoli, luogo del loro matrimonio, Parigi, luogo del viaggio di nozze, la silenziosa Sorrento, dove va a villeggiare la malaticcia Beatrice, e la frenetica Castellammare, dove appunto l’aristocrazia napoletana gode, d’estate, tra feste e divertimenti. A Sorrento ha preferito rifugiarsi Beatrice, sola con Marcello (che però è quasi sempre in cerca di evasioni, spesso a Castellammare), proprio perché garantisce maggiore tranquillità e pace:
«Certo ella sapeva che a Sorrento non cessa completamente la vita mondana e chiassosa dell’aristocrazia; ma ne diminuisce la febbrile attività. Vi è sempre lo Stabia Hall a Castellammare, sempre le sale dell’albergo Tramontano a Sorrento, dove si balla spesso; ma è un ballonzolo di villa, in abito corto di mussola e cappello coperto di fiori: si termina a mezzanotte, si va a letto ad un’ora modesta».
La differenza di allora tra Sorrento e Castellammare un po’ oggi sorprende.
Nella “malinconica” Sorrento si recano Amalia Cantelmo e Fanny Aldemoresco, le amiche dell’isolata Beatrice, per distoglierla dalla noia, se pure per una sera, partecipando ad una delle chiassose feste che a Castellammare si tengono in uno dei pochissimi locali della provincia, il “baraccone” dello Stabia Hall. Le due asseriscono che a Castellammare per divertirsi lavorano «da mattina a sera [...], come i negri delle piantagioni. [...] Figurarsi con quel po po’ di svaghi, con tanta aristocrazia straniera, con tutto il nostro circolo, se è il caso di essere malinconica»:
«— Tu diventi romita, solitaria; a momenti pronunci i voti monacali: noi non possiamo permettere questo.
— Sei diventata invisibile, cara.
— Non tanto, mi sembra. Ma mi sentivo stracca dell’inverno e volli riposarmi. Sento dire che a Castellammare mettete il mondo sossopra.
— Sicuro, sicuro, il mondo a soqquadro. Lavoriamo da mattina a sera per divertirci, come i negri delle piantagioni. Non riposiamo un minuto solo. Non trovi, Beatrice, che facciamo diventare un’ironia la quiete della campagna? Ma non importa; tutte le cose molto regolari sono regolarmente noiose. Non ti annoi qui, Beatrice, malgrado il bel fresco che vi regna?
— Qualche volta mi ci annoio; ma per poco.
— Perché non scendi anche tu a Castellammare? — chiese Amalia, senza lasciare il suo tono indolente.
— No, cara. Non voglio ammalarmi per troppo divertimento. Ci state voi per me...».
Il discorso cade per un po’ sugli assenti mariti, rimasti a giocare al biliardo a Castellammare:
«Se si tratta di accompagnarci, di venire a fare una visita con noi, li vedi lí illanguiditi, morenti, incapaci di muovere un passo; ma quando si tratta di dar dei colpi di stecca, contro le palle d’avorio, sopra un tappeto verde, sono pronti. Lo chiamano un esercizio refrigerante: la grazia del refrigerio!».
Poi si trova il modo di arrivare al dunque e dichiarare lo scopo della «missione diplomatica»:
«— Ebbene cosí alla lesta: ti vogliamo sabato sera allo Stabia.
— Che si fa?
— Si balla, come è naturale; ti vogliamo assolutamente per questa volta.
— Ma se non sono mai andata laggiú.
— Ragione di piú per venirci. È un ballo di beneficenza per i poveri.
— Potrei mandare del denaro senza venire...
— Carità poco evangelica, mia cara — aggiunse con gravità Fanny — massima poco cristiana. Bisogna divertirsi e beneficare. Poi avremo gli ufficiali della corvetta francese che vengono tutti. Dobbiamo abbagliarli, incantarli; tutte sotto le armi, e che armi! Se tu manchi siamo perdute...».
Beatrice non sa piú dire di no e si informa se allo Stabia Hall tutte porteranno i fiori sugli abiti:
«— Ne saremo coperte. Io avrò dei grossi gruppi di papaveri; stan bene con la mia tinta bruna.
— Io avrò dei giacinti. Il giardiniere dell’albergo è in giro per procurarmene.
— Ci penserò anch’io domani. Abbiamo qualche bel fiore nella serra».
è offerta cosí l’occasione per visitare la serra, il «nido campagnolo» di Beatrice, che offre una «pace incantevole» sí, ma non del tutto allettante per le due amiche:
«Cosí si posero in giro. Le due amiche trovavano bello, tutto bello. Una pace incantevole, che non si conosceva in quel frenetico Castellammare. Pure, due o tre volte scambiarono un’occhiata d’intelligenza, dietro le spalle di Beatrice che le precedeva».
E Beatrice, pur timorosa di ammalarsi «per troppo divertimento», va poi in carrozza con Marcello alla festa, della quale la Serao descriverà alcuni momenti, alcuni personaggi e la suggestiva atmosfera attraverso i ricordi che assalgono la protagonista durante il percorso del ritorno a Sorrento.
Andiamo subito alla bellissima scena della fine della serata:
«Sulla porta dello Stabia alcune signore si trattenevano ancora un poco a discorrere fra loro, prima di partire. Parlottavano sottovoce, con certi scoppietti di riso, raccogliendo i loro strascichi per salire in carrozza; al chiaro della luna brillavano i fili d’argento di una mantiglia ricamata. Esse si scambiavano presto presto le impressioni del ballo, il nuovo valtzer di Metra, dal ritornello cosí stridente ma che solleticava i nervi, lo scandaluccio della Filomarino che aveva ballato quattro volte con Mimí D’Alemagna, l’abito verde a fiori gialli, un ardimento strano, della Vanderhoot; prolungavano il loro piacere in quel dialoghetto vivace, spezzato da esclamazioni e da risatine. Intanto la sala si vuotava lentamente. I villeggianti di Meta, di Vico Equense, di Pianosorrento erano già partiti. Beatrice finalmente si decise a staccarsi dal gruppo delle sue amiche. Molti buona sera e dei buon viaggio risuonarono nell’aria, qualche bacio fu scambiato; Marcello, che attendeva, discorrendo con Aldemoresco, Cantelmo e Filomarino, si accostò ed aiutò sua moglie a salire in carrozza».
Il viaggio di ritorno, prima attraverso la città che dorme e poi la strada per Sorrento illuminata dalla luna piena, è appunto un momento di ripensamenti, impressioni e ricordi della festa, nonostante la stanchezza e l’ora inducano al sonno:
«La carrozza partí al piccolo trotto per la via principale di Castellammare. Le case erano buie. Solo i saloni degli alberghi erano ancora illuminati, aspettando qualche dama in ritardo del ballo. Ma presto la carrozza cessò di rotolare sul selciato della città e, rallentando il suo trotto, prese ad ascendere quel nastro sinuoso che è la via per Sorrento. Alle tre del mattino, in quella notte di settembre, sembrava giorno. Certo non un giorno fulgido, dal colorito di sole, ma un giorno biancastro, settentrionale, molliccio e placido. Nel plenilunio tutto diventava candido; pareva che larghe falde di neve, chete, tranquille, si fossero posate dalle colline, pei villaggi, al mare. La strada polverosa, giallastra, s’imbiancava anch’essa.
[...] Beatrice rimaneva nel suo angolo, non tenendosi diritta come al solito, ma abbandonandosi un poco alla spalliera. Nel suo abito di foulard bianco-appannato, a pisellini rossi, ornato di merletti bianchi dallo strascico a sbuffi, qua e là sostenuto da gruppi di garofanetti bianchi a puntini rossi, era stata adorabile, non era rimasta quieta un momentino sulla seggiola. Aveva ballato molto, molto. Marcello, no; due o tre volte lo aveva veduto girare per le sale, ozioso, incapace di prendere interesse alle quadriglie e alle tavole da giuoco, con una noia mortale, che gli si leggeva negli occhi. Né lei gli aveva chiesto nulla; sapeva da tempo quanto lo infastidissero i balli. Ora ella si lasciava andare al senso beato di riposo, in una carrozza che camminava senza scosse, in un’aria benefica e dolce [...].
[...] Non voleva dormire no; anzi pensava ostinatamente che le avrebbe fatto male addormentarsi al fresco della notte, nella sua carrozza scoperta. Cosí, per sottrarsi a quel torpore, per persuadere se stessa di essere bene sveglia, voleva fissarsi sopra un’idea; chi pensa, non dorme, nevvero? Cercava riunire tutte le impressioni del ballo, ricordare per filo e per segno quanto ella aveva fatto, quello che aveva visto fare agli altri; ma si accorgeva di perdere un ricordo, mentre ne trovava un altro; mancava il filo che li congiungesse tutti. Alla porta della sala stava per ricevere le signore il duca di Rivela; sí, il duca. Non era lui che l’aveva maritata a Marcello? Sí, ma questo non ci entrava. Voleva farsi venire in mente con chi aveva ballato il primo ballo. Con Mimí D’Alemagna, che dopo si era dedicato esclusivamente alla Filomarino. Marcello girava per le sale pallido e muto, con la noia dipinta sul viso. La Giansante , nei lancieri, aveva fatto una riverenza troppo profonda, si era impigliata nella veste ed era caduta; molte signore avevano riso, nascondendosi dietro il ventaglio. Il breve cotillon rustico ella lo aveva ballato con Paolo Collemagno, che le sedeva daccanto, negli intervalli, pallido e taciturno come suo marito, quasi fossero attaccati ambedue dalla stessa fatale malattia. Ella, che si sentiva gaia, gli aveva chiesto: «Che avete, Collemagno?». Egli, con la sua voce dolce e rispettosa, le aveva risposto: «Grazie, signora, niente». Poi ad ogni giro di waltzer l’aveva trascinata via con un ardore febbrile. Ella udiva ancora nell’orecchio il ritmo acuto, stridente, quasi beffardo del waltzer di Metra; le pareva di ballarlo ancora con Paolo Collemagno, sbiancato nel volto e silenzioso; le pareva di ballarlo sulla via che dava sul mare, senza parapetto, senza siepe; le pareva che Marcello girasse ancora intorno ad essi, vivente ritratto di Paolo, fratello di Paolo: le pareva che irremissibilmente l’ironico ritornello del waltzer la trascinasse sull’orlo della via dove era il pericolo, il pericolo d’una caduta profonda, profonda, profonda...
La carrozza dette un grande balzo contro un sasso e Beatrice si scosse di soprassalto dal suo letargo, si guardò d’attorno; avevano fatto piú della metà del cammino».

La Parte Sesta del romanzo ci offre una descrizione di Sorrento e Castellammare nei primi giorni di maggio, insolita per i villeggianti. Marcello ritornava con Beatrice malata per amore nella sua villa sorrentina, con la speranza di vederla ristabilita:
«In quei primi giorni del maggio, Sorrento rappresentava il colmo della primavera, nella giovinezza allegra del suo verde e dei suoi fiori. [...] Ma i vasti alberghi di Castellammare erano quasi deserti. Lo Stabia’s Hall, enorme baraccone di legno, aveva un’aria goffa, tutto chiuso; da Castellammare a Sorrento le ville avevano le porte serrate a catenaccio, le gelosie sprangate; solo in capo a qualche viale appariva un giardiniere in maniche di camicia, cappello di paglia, un rastrello in mano».
Ma il percorso del ritorno a Napoli, che pure offre uno spaccato vario se pur breve di una diversa Castellammare, è triste. Un corteo funebre riporta a Napoli la salma di Beatrice, morta a Sorrento:
«A Castellammare giunsero alle cinque. Lo zio Domenico venne di nuovo a parlamentare; i cavalli avevano bisogno di riposare, di rinfrescarsi, per continuare fino a Napoli. Giusto vi era lí l’Hotel de la Paix, dove si poteva posare per una mezz’ora.
Le vetture sarebbero rimaste nel cortile spazioso. Marcello doveva discendere; quattro servi rimarrebbero a guardare gli equipaggi. Tutto sarebbe andato in perfetta regola [...].
Dopo poco si ripartí nel medesimo ordine. Dalle finestre del cortile tutti i servi dell’albergo e i pochi villeggianti guardavano partire il corteggio. Per la via, una bambina si accostò alla carrozza di Marcello e strillava:
— Signorino, datemi un fiore! Signorino, datemi un fiore!
Marcello prese un grande giglio e glielo dette. Ma quando furono passati, la mamma della bambina le strappò il fiore di mano gridando:
— Fiori di morto, malaugurio! Butta via.
Egli non udí, nel rumore delle ruote. Ora le carrozze trottavano ad un buon passo, in una via di pianura, che costeggiava la strada ferrata. Un polverio si levava. Ogni tanto s’incontrava un villano a cavallo del suo asino; il villano, involontariamente, si cavava il cappello. Marcello numerava gli alberi della via, come per fissare in qualche cosa il pensiero che gli sfuggiva. Poi la stanchezza lo vinse. L’ora da Castellammare a Torre Annunziata gli parve un’eternità».

(Da «L'Opinione di Stabia», XI 119 – Agosto-Settembre 2007, pp. 18-19; 23).
(Fine)
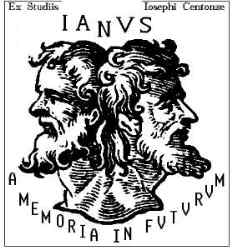
|
Altre Spigolature |