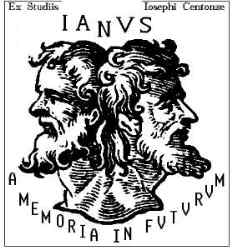GIUSEPPE CENTONZE
Le 'impressioni' di R. Martire
(Ottobre-Novembre 2006)

Natura ed Arte, «Rassegna quindicinale
illustrata italiana e straniera di scienze, lettere ed arti» fu una bella e
diffusa rivista divulgativa, pubblicata a Milano da Vallardi dal 1891 al 1911,
quando si trasformò in mensile col titolo La cultura moderna.
Vi scrissero importanti scrittori (citiamo Matilde Serao, Grazia Deledda, Luigi Capuana) e vi scrisse nel 1895 anche un poco noto scrittore umoristico, forse calabrese, Raffaello Martire, il quale, ritornato dopo venticinque anni in villeggiatura a Castellammare insieme col suo amico Ciccio Vitari, volle presentare la città ai lettori italiani attraverso brevi descrizioni delle sue bellezze e risorse e una serie di briose ‘impressioni’ su personaggi e fatti, suscitate durante i due soggiorni e messe a confronto, quasi a voler documentare i diversi momenti e le variazioni dovute al trascorrere del tempo.
Nel divertente e ironico articolo, piuttosto ampio e perciò pubblicato su due numeri della rivista, intitolato A Castellammare. Impressioni vecchie e nuove, egli fotografava un paese bellissimo e alla moda, ma con i problemi sociali che colpivano Napoli e dintorni.
Riproponiamo in parte il suo piacevole racconto (non senza le sue amare considerazioni), che distribuiamo anche noi in due diversi numeri.
L’autore iniziava rievocando innanzitutto i continui giri fatti una volta nei tipici carrozzini tirati da un asino:
«D’allora è passato quasi un mezzo giubileo, e pure ne ho sempre presente e vivo il ricordo come di cosa seguita oggi! Capitato a Castellammare insieme col buon Ciccio Vitari, la facevamo trascinare tutto il santo giorno da una di quelle carrozzelle tirate da un asinello, fatte di legno e tela, e cosí leggiere, compreso l’asinello, che pareva dovessero andare a mille pezzi al minimo urto. Il fiaccheraio –un giovanetto imberbe– frustava furiosamente l’agile e paziente bestia, la quale non che galoppare volava, volava da meritare il nome di asino alato. Io, sebbene uso allo strano ballonzolio delle vetture di Napoli, ebbi le costole ed altre parti indolenzite per una settimana».
Dopo il «mezzo giubileo», egli registrava la sostituzione dei cavalli e delle carrozzelle guidate da abilissimi cocchieri ai famosi asini locali:
«Nel rivedere dopo tanti anni Castellammare poche cose ho trovato mutate, e, fra l’altro, la sostituzione delle pubbliche vetture di piccoli e forti cavalli ai leggendari somarelli. Dunque Castellammare non ha piú asini? Adagio; ce n’è pur sempre una larga rappresentanza, e per vederli basta indirizzarsi lungo la via erta e faticosa che conduce alla montagna, dove, a un certo punto, se ne trova un gruppo di una ventina, insellati e pronti a portarti su. Tramontati gli asini, dunque, che era una caratteristica attrattiva di questi luoghi, ma non finita, o almeno attenuata, la incresciosa petulanza dei vetturini, i quali a ogni passo t’offrono cento volte il legno. Egli è vero però che, una volta saliti sul piccolo veicolo, il tuo auriga fa schioccare la frusta, il cavallo si mette a corsa sfrenata e tu hai la magra soddisfazione di sapere come si comincia, ma non già come e dove si vada a finire! Tuttavia non devi impaurirti per questo: in nessun paese del mondo il cocchiere è cosí abile ed esperto come nel napoletano, perché egli guida e dirige la sua rozza frammezzo a un vero labirinto di vetture, di pedoni e di straducole, senza che segua alcun urto o altro inconveniente».
Seguiva il gustoso ricordo delle passeggiate sul bel lungomare e di un appariscente personaggio, dall’aspetto aristocratico, che si faceva notare all’ora del tramonto:
«In quei luminosi e tersi pomeriggi di
estate cominciava il su e giú per la riviera, una delle piú amene e ridenti di
quante ne contano i tre mari onde è bagnato il bel Paese. E mentre si
passeggiava mi aveva dato nell’occhio un signore panciuto e
rotondeggiante dall’ampio cappello di paglia; baffi e favoriti come
piantati su di una faccia larga e gioviale; sottoveste di irreprensibile
candore; colletto alto e diritto; cravatta bianca; scarpine verniciate a
coppale, che lasciavano vedere, stando egli colle gambe a cavalcioni, delle
fini calze colorate a righe verticali, come a quel tempo usava, certamente di
seta giapponese.
– Chi sarà mai? chiesi al mio amico.
– Uhm! Qualcuno dei tanti principi, duchi e marchesi napoletani sparsi per quelle ville... e m’indicò col braccio teso la incantevole collina di Quisisana.
– Credo piuttosto che sia un signore straniero: non vedi que’ favoriti tesi, biondicci che ora egli liscia con la mano inguantata, e che gli dànno l’aspetto e il sussiego di un banchiere tedesco o di un lord inglese?
– O che i soli stranieri hanno i favoriti?
– Capisco, ma...
– Ma che?
– Non mi hai tu detto che sulla montagna, in quei sontuosi alberghi, Regina Margherita, Gran Brettagna, Pensione Weiss, villeggiano anche ambasciatori?
– Sicuro; e presentemente ne abbiamo tre: quello di Germania, e altri due, non so se inglesi o russi.
– Sarà dunque un ambasciatore.
E saldi in cotesta persuasione si continuò non pure ad ammirare, ma ad invidiare in cuor nostro il pettoruto signore dalle calze di seta giapponese. Del resto, la nostra supposizione era anche suffragata dalla circostanza che quel bel tipo esotico di gaudente si vedeva solamente nell’ora del tramonto al consueto aristocratico passeggio. Forse nelle altre ore del giorno era occupato a redigere col suo fine tatto note diplomatiche sulla quistione d’Oriente.
Senonché il modo e il fare del nostro gentiluomo era tale, dava tanto nell’occhio che, pur acconciandosi alla ipotesi che egli fosse un gran plenipotenziario, restava sempre la curiosità di sapere quale grande Potenza precisamente rappresentasse. Ambasciatore o ministro! Obbligatissimi: ma di quale Stato, mio Dio? E quale nome pieno zeppo di consonanti scorbutiche aveva egli? Se noi non si fosse conosciuto il gran Cancelliere tedesco per averlo veduto chi sa mai quante volte nelle numerose incisioni e litografie, c’era da scambiarlo, parola d’onore, per Bismark. Dirò di piú, non ho mai ammirato alcun Bismark piú Bismark di lui.
E cerca, fruga, investiga, indaga, sapemmo alla fine –e n’era tempo!– il suo nome e la sua qualità. Signurí –ci disse un marinaio– chillu è u barbiere e Gragnano... Il creduto diplomatico estero era dunque il barbiere di Gragnano, cioè, del paese dove si fanno i piú squisiti maccheroni del mondo! Oh quella pancia rotondeggiante era ben una rivelazione, e noi non fummo buoni a trarne alcun indizio!».

Poi l’attenzione era rivolta all’interno della casa dove il Martire aveva trovato alloggio in entrambi i soggiorni stabiesi, al padron di casa Don Ciccio, impiegato del lotto e giocatore egli stesso, alla sua consorte Donna Filomena, alla cagnetta Miss, che si svegliava per mangiare solo al secondo piatto. A distanza di tanti anni don Ciccio aveva mantenuto la forte passione del lotto e il nostro raccontava con disappunto che un brutto episodio capitatogli (il furto di una somma di denaro ai bagni) fosse stato l’occasione non di un dispiacere per il padron di casa, ma di una fortunata giocata:
«Dopo venticinque anni sonati ho trovato
Don Ciccio naturalmente vecchio d’anni e di malanni e piú ostinato che
mai nella mala abitudine del lotto; ma non ho trovato la cagna del secondo
piatto.
Castellammare, questa deliziosa stazione climatica e balneare, che in fondo in fondo è una Napoli in miniatura, ha tutte le consuetudini, gli usi e le tradizioni della grande, popolosa, geniale e pittoresca metropoli: la brutte e le belle, e fra le prime cotesta del giocare al lotto, che ammiserisce sempre piú la gente, già per tanti versi ridotta quasi allo stremo.
Né è il solo popolo a correre le sorti del gioco del lotto; anche i signori, come qui chiamano gli abbienti, vi sprecano di ben grosse somme, e tutti sanno di una gran dama, moglie di un altissimo personaggio politico, la quale, quando è qui nell’estate, non lascia passar settimana senza mettere un bel gruppetto di lire sopra un bravo terno, che non vince mai. E il popolino pensa che se le grandi dame giocano, vuol dire che ci è da guadagnare. Si sa chi non risica non rosica; ma intanto il nostro Don Ciccio se non facesse l’affíttacamere non rosicherebbe mai, neppure il primo piatto! Beata la Sardegna, dove non c’è lotto! disse un giorno Vitari volto a Donna Filomena; ed essa, forse soprappensiero, sgranando gli occhi rispose: E come fanno a passare dal sette al nove?
I giocatori poi, appassionati dell’arte cabalistica, traggono partito da ogni nonnulla pur di cavare numeri. Nei giorni passati, verbigrazia, mentre facevo il bagno nell’Eden Stabiese uno dei soliti ignoti dall’adunco artiglio, salito nel camerino dove io mi ero svestito, ghermí il mio portafogli e ne portò via quella cinquantina di lire ond’ero provvisto... Narrai la cosa al mio vecchio affittacamere, il quale, lungi di avere una parola di compianto per la mia povera moneta, cominciò a trarre oroscopi dal fatto e dalle sue circostanze; prese quindi la Smorfia, o libro dei Sogni, scartabellò per un pezzo le immortali e logore pagine, poi uscí. Ho saputo dopo che egli, ed altri con lui, cavati cinque numeri da quel piccolo infortunio, giocarono e vinsero in tutti a un dipresso quello che io avevo perduto. E nella brutta faccenda il piú, dirò cosí, giocato sono stato io!».
Amara la riflessione fatta a questo punto dal Martire servendosi della nota e fortunata immagine di Napoli come paradiso abitato da diavoli:
«Bel paese, ma gente, dirò cosí, non bella! La zona perivesuviana fu dai poeti definita un pezzo di cielo lanciato da Dio in terra in un momento di collera. E non dico di no; anzi mi conferma in questa sentenza il fatto di vederla abitata da angeli ribelli, o se piú vi piace, da diavoli».
Ed ecco la spiacevole esperienza del furto, che aveva segnato il nostro a conclusione di un bagno di mare reso suggestivo dai sogni evocati dall’affascinante paesaggio e dall’atmosfera creata dalle canzoni napoletane che giungevano all’orecchio:
«Nell’Eden Stabiese, il migliore stabilimento dopo quello della Vittoria a Portocarrello, rinomato quest’ultimo per i bagni marini-solforosi, ho udito cantare le piú gaie e caratteristiche canzoni napoletane. Sono in tre o quattro con chitarra, mandolino e violino, e quando tu, cullato dalle acque chete com’olio gusti le melodie che quei musicisti lanciano nell’aere azzurro, ammiri Rovigliano e il suo castello pensando a’ trovieri sospiranti le belle castellane, e ti senti come rapito in altri tempi e cieli, un bello spirito, che può essere benissimo il tuo vicino bagnante, raggiunta di soppiatto la scaletta del camerino, rapisce il tuo portafogli... Fatto il bagno, tu corri, grondante e intirizzito ad asciugarti; ti rivesti, dai una passatina di pettine a’ capelli e alla barba, umidi ancora dall’amplesso dell’acqua salata, zufolando Dormi, Carmè, U cchiú bello d’a vita è dormí, frughi in tasca per dare la solita mancia... e allora solamente ti ricordi di essere nel napoletano!».
Con quest’altra amara considerazione interrompiamo le argute nonché imbarazzanti ‘impressioni’ di Raffaello Martire, che continueremo nel prossimo numero.
* * *
Proseguiamo con le gustose «impressioni vecchie e nuove» su Castellammare, descritte nell’ironico articolo di Raffaello Martire uscito nel 1895 su Natura ed arte, cominciando da una «piaga» di allora, le mosche, di cui l’autore parlava dopo aver toccato il problema della scarsa pulizia, notata nei pur lussuosi camerini dello stabilimento termale e persino nell’acqua benedetta delle chiese:
«Una delle piaghe di Castellammare sono... I pezzenti? No; quelli si possono tollerare; sono le mosche. Dio buono quante e come noiose! Se vai, puta caso, dal barbiere per quella periodica tortura che si chiama farsi radere o spuntare la barba, trovi il cosí detto garzone-automatico, un ragazzino per lo piú macilento, che, munito di un fragoroso scacciamosche, te lo agita attorno al capo durante tutta l’opera, spesso lunga, del lavorante. Eppure, nonostante questo refrigerio, la mosca trova modo, tra una scacciata e l’altra, di posarsi sulla punta del naso, o sugli occhi, con quanto gusto si può immaginare! Non dirò poi quando si mangia: allora è una lotta formidabile, e spesso nel fervore dell’aspra battaglia, la forchetta non trova piú la via della bocca, e va a finire chi sa mai dove! Ora che scrivo, mi dànno un po’ di tregua perché –solo rimedio– ho socchiuso le imposte e lavoro in una specie di penombra. Se te ne duoli con alcuni di questi paesani, ti senti rispondere con grande sicumera: – Voi pazziate? la mosca è segno di buon’aria! E con questa convinzione ti piantano lí».

Proponiamo di seguito quel che il Martire disse di due personaggi della Castellammare di fine Ottocento, don Peppe Cuomo e padre Gesualdo Lumia.
Il primo, proprietario della fonte dell’acqua acidula, decisa e colorita figura di imprenditore locale, era diventato un personaggio tipico della città. Raffaello Martire ne fece un divertente e sferzante ritratto quando parlò delle acque:
«Don Peppe è un simpatico uomo, nero come un tizzo e con due baffoni bianchi che gli dànno l’aria di un sergente degli antichi eserciti a riposo. Egli non è mutato in nulla, se ne togli una sensibile incurvatura della schiena, e se non ha fatto cambiar di colore ai mustacchi, che sono in notevole contrasto con la faccia d’abissino, gli è perché, io penso, non gli è riuscito di trovare una buon’acqua, pur avendone tante a sua disposizione! La gente del paese, con un linguaggio che mal dissimula una tal quale segreta invidiuzza, dice che egli ha saputo fare bene i suoi conti e che è diventato piú ricco col darla a bere –l’acidola, intendi– al prossimo di quel che non abbia saputo o potuto altri col dar da mangiare al prossimo medesimo. Don Peppe un bel giorno chiamò nientemeno che l’illustre dottore Arnaldo Cantani –le cose si fanno o non si fanno– direttore della prima clinica medica nella R. Università di Napoli, e lo pregò di procedere ad una coscienziosa analisi dell’acqua acidola: il professore –neanche a dirlo– accettò, analizzò, provò che in quell’acqua era un po’ di tutto, e che per la sua indiscutibile efficacia avrebbe guarito ogni male, persino... i calli ribelli, e il pubblico bevve, bevve e beve tuttora con lo stesso piacere onde altri tracannerebbe un boccale di vecchio vino del Vesuvio. L’uomo baffuto, da quell’esperto napoletano che è, trasse il maggior partito dal responso della Sibilla Cantani: fece stampare un infinito numero di opuscoli dirò cosí analitici, con analoga copertina civettuola; elevò sulla piazzetta ove sorge con l’acqua la sua industria, un trofeo di bottiglie acquacidolose artisticamente disposte e fornite di attraenti etichette, ponendo, in cima a cotesto trofeo, un quadrettino con la indicazione dei premi conseguiti in non so quante esposizioni e con le medaglie relative; ordinò, infine, con proprietà maggiore la industria stessa e mise, fra l’altro, al servizio dei numerosi avventori d’ogni lingua e paese, certi valletti –vulgo guagliuni– vestiti, anzi senza vestito alcuno, di leggiere maglie a righe rosse e bianche, mutandine corte, berretto alla marinara e a piedi ignudi. Don Peppe, che ha gli occhi dappertutto e che tutto vede e tutto sente, appena annasa una comitiva di bevitori o una carrozza, conta con rapidità fulminea, come Napoleone gli eserciti nemici, le persone della comitiva o della vettura, e ordina due, quattro, fino a otto bicchieri. La tariffa, fissata piú che dal conduttore dell’industria, dalla consuetudine, è di cinque centesimi ogni due bicchieri; e puoi figurarti quanti centesimi entrino nel borsellino di Don Peppe. Il quale un tempo dava gli ordini a voce, gridando come un aquilotto: oggi, in ossequio alla civiltà crescente, si giova di una sorta di fischietto o zufolo, che manda un suono trillante, e delle mani: fischia e i valletti puntano le scintillanti pupille su di lui, che con le braccia in alto e le dita tese indica il numero dei bicchieri. L’ordine viene eseguito assai piú presto che non occorra di tempo a darlo, e se mai di un minuto si tarda soccorre la voce stentorea del padrone. È uno spettacolo curioso e insieme dilettevole, perché tu stando seduto e sorseggiando quell’acqua, la quale è fresca e non ha alcun sapore, vedi sfilare innanzi a te gente d’ogni parte e d’ogni condizione, dall’umile provinciale, che accorre a bere con la devozione medesima con cui visiterebbe il Santuario di Pompei, all’altera Principessa che, facendo fermare la magnifica victoria, accosta le rosee labbra al bicchiere limpido e... plebeo».

Il secondo, padre Gesualdo Lumia (se il nostro autore ha lasciato il vero nome), era il guardiano del «monastero dei Cappuccini, su alle falde della montagna» (dovrebbe trattarsi del convento dei Francescani Minori a Quisisana chiamato dei Cappuccini perché appartenuto in passato a questi frati; ma il guardiano allora era il p. Emanuele Lucia da Castelcivita), una figura semplice e gioviale di francescano, che sapeva tenere un contatto originale e genuino con la gente e che Martire aveva voluto visitare anche durante il suo secondo soggiorno. Il nostro ne parlava dopo aver accennato alle cose notevoli di Castellammare (al cantiere navale, alle bellezze di Quisisana, infine al Santuario di Pozzano, che gli aveva fatto venire in mente il guardiano del convento dei «Cappuccini»):
«Conoscete il padre
Gesualdo Lumia? No: ve lo presento. Egli è guardiano nel monastero dei
Cappuccini, su alle falde della montagna. Noleggiata la solita carrozzella, ci
si fece condurre sino alla porta dell’antico cenobio, dove giunti chiesi
di Gesualdo, con un po’ di trepidazione, poiché non vedendolo da tanti
anni, né avendo saputo piú nulla di lui, temevo mi si rispondesse essere già
morto e seppellito.
– è giú per le scale, disse un novizio: se aspettate un momento, lo vedrete. E attesi.
Egli si dirigeva adagio adagio, erto il capo, verso l’usciuolo del suo piccolo appartamento, due modeste celle. Gli corsi incontro, lieto di rivederlo e gli stesi la mano ricordandogli il mio nome. Il frate mi guardò fiso, corrugando le ciglia e stringendo le labbra; poi volse gli occhi verso il cielo come per rammentarsi dove e quando mi avesse conosciuto, quindi fece: – Già, già, – e senza aggiungere altro mi precedette schiudendo la porticina.
– Padre Gesualdo, sono meco delle signore, dissi, e gli additai gli altri della comitiva.
– E vengano pure le signore, rispose sorridendo e senza scomporsi, qui non ci è clausura; di sopra sí, e indicò le ampie scale.
Attraversata la prima stanzetta, dov’era un lettuccio e un tavolino, entrammo nell’altra, un po’ meno angusta, che ha una loggetta inghirlandata di piante rampicanti e fiorite e di grappoli d’uva, i quali apparivano d’oro a’ raggi del sole volgente al tramonto.
– Guardate che vista! dissi e feci appressare le signore alla poetica loggetta.
– Che magnifica conca eh? disse padre Gesualdo, annasando una presa di tabacco, ma ne sparse piú sull’abito che non ne aspirò...
– Meravigliosa! esclamammo ad una voce. Trattolo poi in disparte, gli mormorai quasi all’orecchio:
– Ricordate quando ci vedemmo l’ultima volta? Fece un gesto con la mano come dire: Cosí in sogno.
– Ricorderete che mi faceste sentire i vostri graziosi ballabili?
– Ah!...
– E che cantaste le gaie canzonette napolitane?
– Sicuro! ma... ora non canto piú: da quando ebbi la nomina e il peso di guardiano non ho fatto piú nulla; me ne manca il tempo; sono assediato da ogni parte...
– Forse le penitenti...
– Per carità, e si allontanò di un passo come inorridito, non ci mancherebbe che la confessione!...
Poi batté con la mano sulla tabacchiera con un lieve senso di mestizia, e mi fece capire nel suo spiccato accento napoletano che, pur consentendogli la grave età di cantare, non sarebbe stato conveniente il farlo, atteso il nuovo e grave suo ufficio.
Perché padre Gesualdo non è un religioso comune, di mediocre coltura: egli un tempo ebbe rinomanza come predicatore, fu amabile e originale compositore di musica sacra e profana, e forse piú di questa che di quella; cantante pregevole sull’organo e alla spinetta; aggiustatore e accordatore, a tempo perduto, di pianoforti; parlatore geniale; insomma tipo di frate singolare, di quelli di stampo antico.
Ogni sua frase è un’arguzia; ogni suo discorso scoppietta di spirito e di cosí felici osservazioni a proposito di uomini e cose, che non puoi fare a meno di sorridere e di ridere. E le parole accompagna coi gesti e i gesti colorisce con certi modi di dire tutti affatto speciali di questo brioso e gaio popolo. Noi si stava a sentirlo col medesimo diletto onde si assisterebbe a una commedia di Scarpetta o alle scioccherie di Pulcinella; e a vederlo e udirlo ti pareva di vedere e udire, salvo il rispetto alla tonaca e alla persona, Pulcinella camuffato da frate; Pulcinella del quale aveva, a farlo apposta, il gran naso a peperone su cui cadevano gli occhiali a stanghetta.
– Padre Gesualdo sonate un po’, usateci questa cortesia.
– Ch’aggio a sonà, rispose lui, songo viecchiu e song’io u sonato; mo tocca a voi a sonà! e rise.
Tuttavia, a dispetto dei settant’anni e piú, ha una snellezza ed elasticità nella persona piccola e robusta che un giovane gl’invidierebbe. E credo che gli anni non devono ancora pesargli molto sulla groppa malgrado, o forse in grazia dell’austera e sobria vita monastica; e se non fosse per le guance flosce e vizze e per l’assenza assoluta di denti, tranne, forse, quello del giudizio, che accusano in lui l’età grave, nessun altro indizio lo indicherebbe per un uomo che rasenta i tre quarti di secolo.
Una delle signore, che stava a udirlo con molta compiacenza, disse sottovoce alla vicina:
– Parla tanto bene!
Pare che l’ottimo cappuccino la sentisse, perché di un tratto come interrompendosi:
– Eppure, esclamò, se io posso parlare non è tutto merito mio.
– Come sarebbe a dire? osservò la signora.
– Ecco, fece il venerando uomo, e, introducendo con delicata disinvoltura l’indice e il pollice in bocca, ne trasse... la dentiera!
Si provò a balbettare qualche sillaba; niente: pareva il guaito di una cagna.
Si rise di cuore tutti, e padre Gesualdo, da uomo di mondo, rise anche lui e rimise a posto l’apparecchio, nell’atto che figgeva su noi due occhietti ancora fiammeggianti di fuoco giovanile.
È superfluo aggiungere che alla fine, incoraggiato forse dalla presenza delle signore, sonò una polka, una mazurka, un walzer, e non so che piú altro. Chiuse quindi con una brillantissima canzonetta napoletana, che ci esilarò. Tutto ciò fra un bicchiere e l’altro di un certo liquore da lui manipolato, e dopo di avere sorbito un eccellente caffè che egli lí per lí preparò in un cantuccio. Poscia distribuí, insieme a delle squisite gallette dolci, parecchie figure di santi e ci accomiatò, che era già notte con queste parole, le quali sono come la sintesi di tutta la sua semplice e nobile vita: Siate allegri, ma fate il vostro dovere e amate Dio!».
La figura di Padre Gesualdo Lumia gli offriva a sua volta l’occasione per passare a Bartolo Longo e a Pompei, ma a questo punto possiamo accomiatarci da Raffaello Martire.

(Da «L'Opinione di Stabia», X 112 – Ottobre 2006, pp. 16-17; X 113 – Novembre 2006, pp. 16-17).
(Fine)